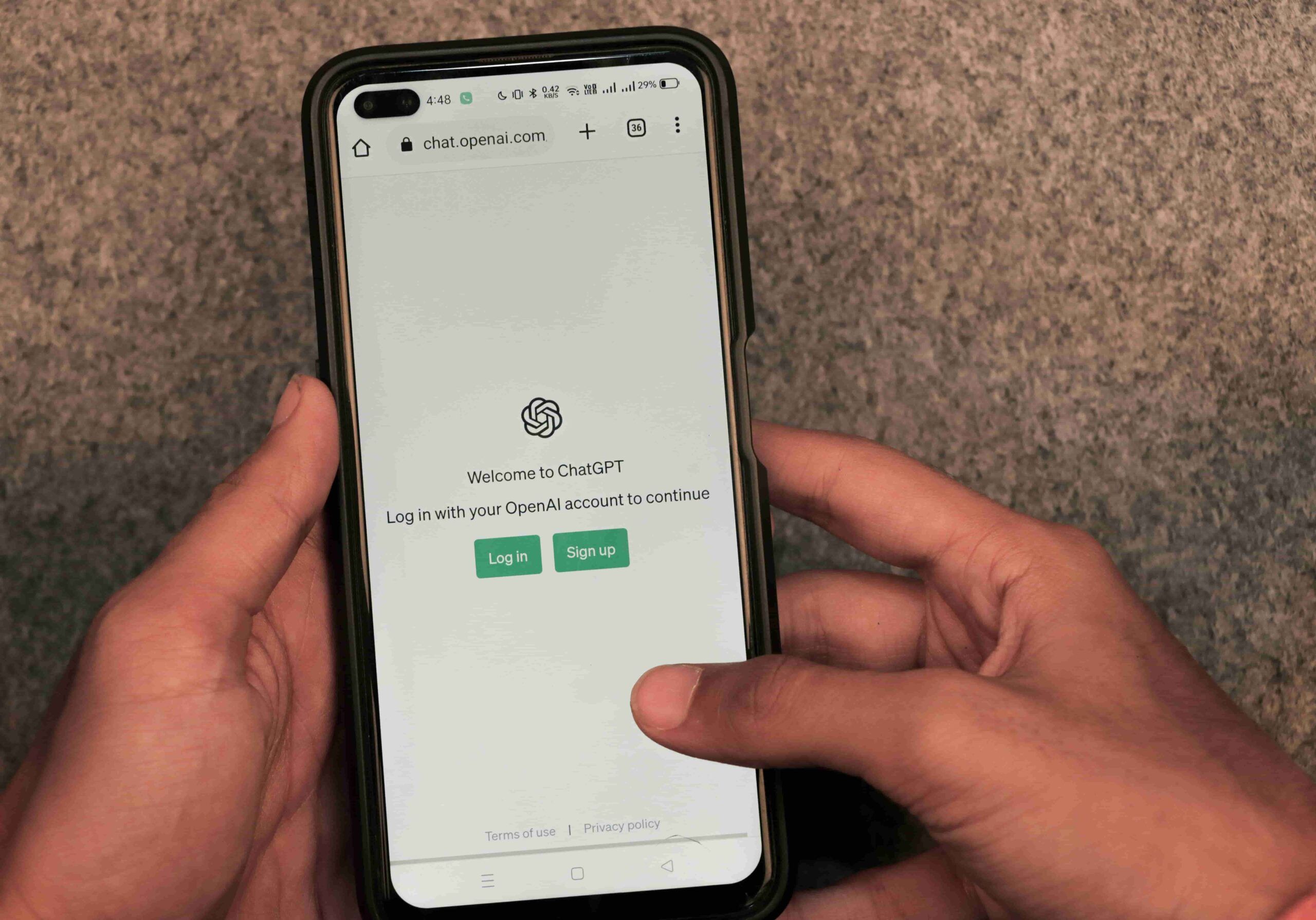Istituti tecnici quinquennali, serve la riforma (con urgenza)
Lo scriviamo da anni che serve una riforma dell’istruzione tecnica secondaria, ma è stata rallentata dalla filiera formativa del 4+2. Stiamo ora arrivando con grave ritardo alla vera riforma, che, integrata in un forte sistema istituzionale assieme all’istruzione terziaria, avrebbe dovuto costituire la nuova architettura di un sistema scolastico di eccellenza. Così non è stato previsto. Si è preferito procedere con soluzioni diverse, che hanno bisogno continuamente di essere commentate, per rappresentare una visione alternativa a quanto viene comunicato.
Anzitutto, per ragioni di chiarezza, dobbiamo intenderci su un punto importante. Se stiamo al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per la Commissione europea la riforma attesa – che concorrerà all’erogazione della quota di finanziamento prevista – è quella dell’istruzione tecnica quinquennale avviata dal Governo che ha preceduto quello attualmente in carica. Solo successivamente, l’apparato normativo è stato integrato con la filiera tecnologica professionale quadriennale della cosiddetta 4+2, la quale tuttavia, per la medesima Commissione europea, non è da considerare sostitutiva della riforma originaria dell’istruzione tecnica quinquennale programmata nel Pnrr.
La filiera formativa del 4+2, che dal 2025-26 diventerà ordinamentale, per quanto abbiamo già scritto è prevalentemente un accorciamento dei programmi di studio da cinque a quattro anni. E, “il rinnovo del programma, puntando sulla qualità e sul potenziamento delle materie base italiano, inglese e matematica, creando una inversione di tendenza positivo”, come ha affermato Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito in una sua dichiarazione, non è nulla di nuovo, ma rientra nelle ordinarie azioni di manutenzione dei programmi scolastici di tutti i percorsi ordinamentali.
Non è una buona ragione neppure affermare che le prove Invalsi indichino che in Lombardia i percorsi della formazione professionale quadriennale abbiano prodotto, nelle discipline fondamentali, risultati migliori degli omologhi percorsi quinquennali statali. Ciò, per due motivi: il primo perché si confrontano dati rilevati da un campione di studenti irrisorio, mentre il confronto lo si dovrebbe fare a livello nazionale e non solo sulla Lombardia; il secondo perché con tale affermazione si corre il rischio di delegittimare i percorsi quinquennali statali, che accolgono il 98% degli studenti dell’istruzione tecnica e professionale e, dunque, in questo modo certamente non si incentiva l’attrattività verso gli istituti tecnici, di cui invece ne abbiamo un grande e urgente bisogno.
I paragoni fuorvianti con la formazione estera
Occorre anche commentare il paragone che si fa con i sistemi scolastici esteri, quando si afferma che “il modello a quattro anni mostra performance superiori nei test Pisa (acronimo di Programme for international student assessment, che valuta le competenze degli studenti in lettura, matematica e scienze ogni tre anni, Ndr) rispetto a quelli italiani”. Innanzitutto, nel confronto tra due sistemi – qualunque essi siano – occorre tener conto di tutte le loro ‘dimensioni’: è come se confrontassimo due grandezze vettoriali, solo attraverso la loro dimensione scalare.
I sistemi scolastici esteri, quelli con cui ha senso confrontarsi, sono prima di tutto performanti, ossia nelle classifiche Ocse per l’education sono in ottime posizioni, mentre il nostro Paese non lo è. E i loro percorsi tecnici e professionali non sono percorsi di serie B o di serie C, mentre il nostro sistema scolastico, proprio nell’ultimo Rapporto del Censis, è stato definito “la fabbrica degli ignoranti”, con una percentuale elevatissima di studenti che non raggiungono gli obiettivi minimi di apprendimento in italiano, matematica e inglese. È ragionevole affermare che, per migliorare tali esiti non ci sarebbe bisogno di nessuna riforma, basterebbe invece far funzionare bene la scuola, certamente non con una soluzione che consente di acquisire il diploma riducendo di un anno il percorso di studi. Le riforme servono a ben altro scopo.
Che “le imprese italiane non trovano giovani con le competenze necessarie, rischiando di perdere competitività”, come ha affermato Valditara, lo sappiamo da tempo, ma la soluzione non è la filiera formativa 4+2. Ho scritto appositamente un libro e continuo a scrivere articoli per allargare gli orizzonti su questi argomenti confinati in un perimetro molto ristretto, e che avrebbero bisogno di un grande dibattito. E la ragione per cui la 4+2 non può essere la vera sfida della scuola del futuro, è anche conseguente a un fatto concettuale tecnico molto semplice: la sua architettura formativa non trova una collocazione ragionevole nel perimetro delle architetture di un sistema di istruzione tecnica, che deve essere coerente con gli insiemi di saperi e di cultura che attengono alle tre classificazioni dedotte dal quadro delle professioni tecniche.
Il flusso logico – da tenere sempre presente – che dovrebbe costituire una delle dimensioni del capitolato di riforma, collega il quadro del sistema economico, in tutte le sue articolazioni, con il quadro delle aree delle professioni in tutte le loro dimensioni, per giungere al quadro dei percorsi formativi con tutte le loro architetture. Dentro questi perimetri di rappresentazione sistemica, che sono essenziali per l’individuazione dei saperi e dei contenuti, la filiera formativa 4+2 mal si inserisce, se non come una opzione di un intervento di formazione, o addestramento, professionale.
Senza riforma la produttività resta al palo
Non passa giorno che non si lanci l’allarme sul peggiorare di alcuni indicatori economici e sociali che nel post Pnrr – quando verranno a mancare i relativi finanziamenti straordinari – assumerà un rilievo sempre più preoccupante. Ne ha parlato anche una persona autorevole, Salvatore Rossi, già Direttore Generale di Bankitalia, che in una sua intervista a La Repubblica ha descritto un quadro strutturalmente debole per la crescita italiana.
Secondo le previsioni della Commissione europea, l’Italia crescerà meno della media dell’Unione europea, perché le nostre criticità – come spesso abbiamo detto – sono di natura strutturale quindi permanente e non congiunturali ossia legate al ciclo economico. Anche secondo l’autorevole economista, la causa – come rilevato da altri esperti e oggettivamente riscontrata anche dai numeri – risiede nella dinamica della produttività. Lo abbiamo detto più volte argomentando sull’elevato valore del costo unitario per prodotto nonostante i salari bassi.
La mancata crescita della produttività del lavoro e del capitale riduce gli spazi per l’aumento dei redditi e per gli investimenti in innovazione, i due pilastri per sostenere la competitività. Senza produttività non si cresce, non si innova, non si aumentano gli stipendi, non si migliora l’employability, non si riduce il precariato e si mette a rischio il welfare. Ed è la ragione per cui abbiamo bisogno di una istruzione tecnica di eccellenza. È ampiamente scritto nel mio saggio Ricostruire l’istruzione tecnica.
Senza saperi non si costruiscono le competenze
Come ha scritto anche il Cnel nel suo Rapporto recente sulla produttività, l’analisi di Rossi individua nell’assetto del sistema produttivo italiano uno dei principali fattori di freno. Il Paese è infatti caratterizzato da una prevalenza di microimprese e piccole imprese. Anche i gruppi di maggiore rilievo – nella descrizione dell’economista – operano spesso con scale operative ridotte in confronto ai pari settore di altri Stati membri.
La struttura frammentata del tessuto imprenditoriale italiano penalizza i livelli di produttività e la capacità di innovare e rende più difficile competere su mercati globali e innovativi. Anche gli investimenti in macchinari, infrastrutture digitali e innovazione risultano insufficienti a colmare il divario con i principali partner europei. La trasformazione digitale del sistema produttivo procede con velocità eterogenea, con differenze marcate tra settori e territori. È scritto bene nel libro Trasformazione aziendale di Bruno Carminati, Emanuele Farinella, Fabio Gnoato (Guerini Next, 2023).
Un ulteriore elemento critico – che è poi il focus principale dei nostri interventi – riguarda i ritardi nel sistema di istruzione, ovviamente riferendosi prioritariamente all’istruzione tecnica. Detto in altro modo: manca la conoscenza di nuovi saperi e quindi l’impossibilità di costruire le competenze. Ma, purtroppo, manca anche la conoscenza dell’importanza strategica del sistema economico industriale e di come costruire una riforma adeguata dell’istruzione tecnica che sia funzionale alla sostenibilità e crescita economica e sociale, e attrattiva per i nostri giovani.
La necessità di un capitolato per la riforma
L’intervento riformatore degli istituti quinquennali è pur sempre un processo di cambiamento e come tale va gestito applicando correttamente le sue giuste grammatiche. Ci sarebbe bisogno di una preliminare explicatio terminorum per derimere una confusione concettuale e terminologica che ci si trascina da tempo e che inquina le riforme.
Poi, per i vincoli di sistema che si dovranno affrontare, che costringono a scegliere soltanto un approccio bottom up, occorrerebbe anche avere, ai fini di un adeguamento e aggiornamento dei contenuti della formazione, una buona dose di ‘strabismo’, ossia la capacità di integrare la verticalità degli indirizzi scolastici attuali con l’orizzontalità e quindi la trasversalità degli ambiti applicativi dei medesimi contenuti. Ciò costringerà a ricercare nelle due dimensioni la catena del valore, quella da cui estrarre le informazioni per la costruzione dei contenuti. In questi ambiti organizzativi e lavorativi si individuano le zone nelle quali si deve costruire il protagonismo dei giovani aspiranti tecnici. Queste procedure devono poi fare emergere un’alta attrazione verso il mondo delle professioni tecniche e dell’istruzione tecnica.
Non è sufficiente disporre della miglior riforma, se questa non ha poi un efficace sistema di attrazione che attiri tutti i portatori di interesse. Ecco perché insisto sulla necessità che la riforma dell’istruzione tecnica quinquennale, sia pur nelle ristrettezze in cui è costretta, sia guidata da un chiaro capitolato, inteso come quadro di riferimento concettuale in base al quale progettare, secondo un preciso e articolato processo logico, le linee di intervento.
L’articolo Istituti tecnici quinquennali, serve la riforma (con urgenza) proviene da Parole di Management.