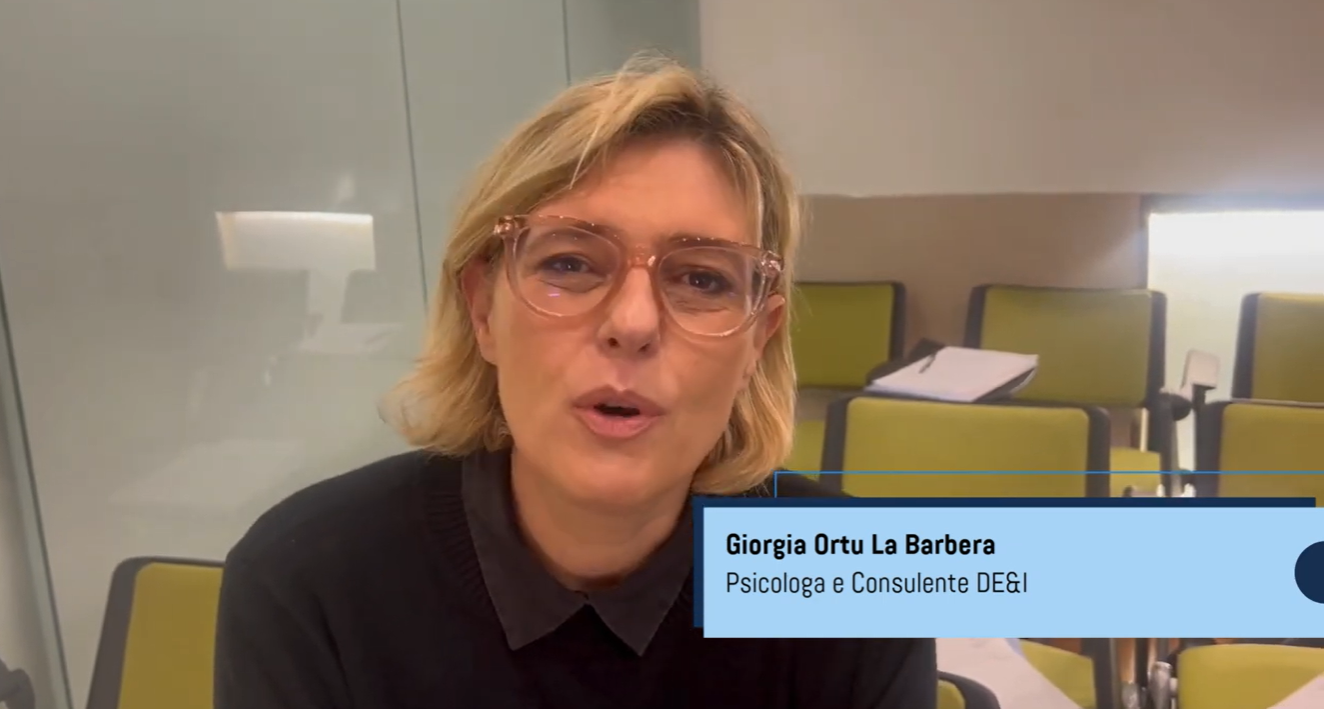Il mismatch: sogno (delle aziende) o amara realtà?
Da tempo sul mercato del lavoro italiano risuona lo stesso allarme: le aziende cercano, ma non trovano personale. Una difficoltà sempre più diffusa, raccontata anche dal Corriere, che fotografa un problema ormai strutturale. In un articolo del 1° marzo 2026, che riprende i dati del Report di Cnel e Unioncamere, il quotidiano riporta che le imprese italiane fanno fatica a coprire le posizioni lavorative ricercate in 46 casi su 100, con difficoltà elevate anche per i laureati, per cui il gap è al 51%.
Il tema è reale. I dati mostrano difficoltà di reperimento in settori come costruzioni, metalmeccanica, elettronica e servizi ad alta intensità di competenze, inclusi informatica e telecomunicazioni. Una parte del problema riguarda la crescita della domanda di profili tecnici e Stem, la transizione scuola‑lavoro non sempre fluida e la necessità di aggiornare costantemente le competenze.
Ma se vogliamo stare sul terreno dell’economia, la domanda da cui partire è un’altra: se le imprese non trovano lavoratori, quanto dipende dalla reale mancanza di competenze e quanto dal fatto che l’offerta non è sufficientemente attrattiva?
Il prezzo del lavoro
Nel mercato del lavoro, il ‘prezzo’ non coincide solo con la retribuzione: indica l’intero pacchetto di valore percepito (cultura manageriale, possibilità di crescita, autonomia, qualità dei processi, investimento in formazione, reputazione aziendale).
Se la scarsità persiste, non è solo un problema di offerta: è un segnale del mercato. Questa tensione si vede bene negli indicatori: il tasso dei posti vacanti in Italia si aggira intorno al 2,1% nel quadro recente, segnale di difficoltà di incontro tra domanda e offerta.
A questo si somma un vincolo demografico drastico. Nel 2024 l’Italia ha registrato un minimo storico di fecondità (1,18 figli per donna) e meno di 370mila nascite. È un limite quantitativo: meno giovani significa meno potenziali ingressi nel mercato del lavoro. Parallelamente, aumentano gli espatri: nel 2024 circa 191mila persone hanno lasciato l’Italia, di cui 156mila cittadini italiani. Nel biennio 2023‑24, l’Istat parla di ‘record di espatri’, con una mobilità crescente tra i 20 e i 39 anni.
Ritardi e arretratezze strutturali nelle PMI italiane
Ma allora, perché una parte crescente di giovani non vede il proprio futuro professionale in Italia? Una parte della risposta risiede nella struttura del nostro sistema produttivo. Le PMI, ossatura del Paese, spesso mostrano ritardi su digitalizzazione, formazione, organizzazione e capacità di delega. I dati Istat evidenziano, per esempio, un ampio divario tra PMI e grandi imprese nella presenza di specialisti Information e Communication Technology (Ict), nell’erogazione di formazione informatica e nell’adozione di sistemi avanzati di sicurezza digitale. Tutti fattori che influiscono direttamente sulla produttività e quindi sulla possibilità di offrire salari competitivi e carriere credibili.
Il punto è che il mismatch non è da ricercare fuori dall’impresa (scuola, giovani, università) ma dentro l’impresa: nelle pratiche manageriali, nella capacità di creare contesti in cui le competenze si moltiplicano anziché spegnersi. Il talento entra, ma se non trova processi, strumenti e leadership adeguate, non resta. E l’impresa interpreta la fuga come mancanza di candidati, quando in realtà è mancanza di attrattività.
Ad un certo punto dobbiamo cominciare a dare un nome e un cognome al problema: un aspetto culturale, che ha però conseguenze economiche dirette: una parte del capitalismo italiano tende a privilegiare il controllo più che la crescita. È una cultura dove la delega è vista con sospetto e dove la priorità non è scalare ma mantenere la presa. Ma crescere significa distribuire potere, definire criteri, accettare meccanismi di accountability.
Le aziende devono imparare a farsi scegliere
Il confronto internazionale rende il tutto ancora più impietoso: gli Stati Uniti hanno attratto circa 1,18 milioni di studenti internazionali nel biennio 2024-25, con una quota crescente che rimane a lavorare grazie ai programmi di placement, generando un flusso continuo di competenze, innovazione e capitale umano. L’Italia, al contrario, nello stesso periodo ha visto aumentare gli espatri, soprattutto tra i più giovani.
Lamentare la scarsità di risorse non rende un buon servizio né al mercato del lavoro né alle imprese, va aumentata la capacità di attrarre. Il focus va posto sulla produttività, con salari competitivi e conseguente retention; carriere trasparenti e basate sui risultati, non sulle simpatie; managerializzazione reale, con delega autentica e sistemi di valutazione e reputazione aziendale, perché i mercati del lavoro sono conversazioni.
Per concludere: in un Paese che invecchia e perde giovani, le imprese non competono per trovare lavoratori, ma per farsi scegliere. Perché se oggi le imprese non trovano persone, non è solo perché ‘mancano’. È perché (sempre più spesso) possono scegliere. E scelgono dove vedono futuro.
L’articolo Il mismatch: sogno (delle aziende) o amara realtà? proviene da Parole di Management.